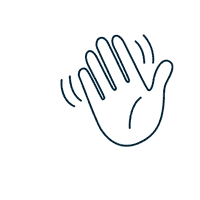Basilicata: storie tra chi resta e chi se ne va
La Basilicata è la regione dove si risente di più il fenomeno dello spopolamento rurale in Italia. Qui dove l’agricoltura rappresenta ancora la principale forma di sostentamento, il 56% della popolazione si concentra solo nei due capoluoghi Matera e Potenza. I paesi che 30 anni fa raggiungevano i 10 mila abitanti, hanno perso più della metà dei loro abitanti. Nel frattempo Matera è diventata la capitale europea della cultura 2019, ma tutt’intorno c’è il deserto. A controbilanciare questa tendenza, ci sono i giovani. Quelli che resistono e quelli che sono tornati a casa, dopo tanti anni al Nord, per cercare di riscattare le loro radici. Ognuno con sogni e speranze diverse.
“E la senti dentro all’aria questa voglia di tornare. Il paese che mi aspetta per rivivere questa festa. E la magia si ripete, ogni anno che ti vedo, non mi posso più staccare, terra mia dolceamara”. Milena e Maria Luigia sono cresciute in un borgo fantasma dove tutto si è fermato agli anni ’50, a meno di un’ora di auto da Matera. La stessa città della Basilicata, nel centro del Sud Italia, che in settant’anni è passata dall’essere “Una vergogna nazionale”, o almeno così era stata definita da Palmiro Togliatti, il vecchio segretario del Pci, il partito comunista italiano, all’essere scelta come “Capitale europea della cultura per il 2019”. Le due sorelle, dopo averci mostrato un paese di sole case senza più anima, dove è difficile distinguere ciò che resiste ancora da ciò che se ne è andato per sempre, ci regalano un cd del cantautore Pietro Cirillo. Un’istituzione per i lucani, e un regalo per noi, per osservare la loro terra da un’altra prospettiva, quella di chi continua a viverci.
Suoni magici, suoni ipnotici. Dalla nostra Ford Fiesta, stipata di mele, grano e meloni gialli, che ci hanno regalato per strada, per affrontare questa a terra a pancia piena, Pietro Cirillo inizia a cantare. Sembra che si sia seduto proprio dietro di noi, giusto in tempo per guidarci tra paesi vuote e strade brulle. E quasi quasi ce lo immaginiamo, cercandolo con la coda dell’occhio nello specchietto. La sua musica, la sua storia, parte proprio da qui: da quel mondo arcaico e contadino, in cui Milena e Maria Luigia sono cresciute. Inizia così il nostro viaggio alla ricerca di chi, nella regione più spopolata della Penisola, ha deciso di rimanere, di chi se ne è andato ma poi è tornato, perché ad un certo punto, come ci hanno insegnato, “Le origini si sentono”, e di chi invece c’è arrivato per la prima volta, dopo una vita trascorsa tra altri venti, tra altre montagne, tra altri mari.

L’unica famiglia di Borgo Taccone ©Veronica Di Benedetto Montaccini 
Le verdi colline lucane ©Veronica Di Benedetto Montaccini 
On the road ©Veronica Di Benedetto Montaccini
I dati
È una lotta. I numeri sanno fotografare la realtà, ancora meglio dei nostri obiettivi. Perché in Basilicata il calo dei residenti è costante. Ogni anno in media quasi 3 mila persone spariscono dalla Lucania. La popolazione invecchia, le nascite sono poche e l’emigrazione avanza: sono questi gli aspetti che caratterizzano una regione destinata presto a fare i conti con la realtà. Secondo l’ultimo rapporto Svimez, l’associazione per lo sviluppo industriale nel Mezzogiorno, nel 2065 la Basilicata scenderà sotto la soglia dei 400 mila abitanti, contro gli attuali 570.365.
In Lucania non ci sono città grandi. Se si escludono i due capoluoghi di provincia, Potenza e Matera che, secondo i l’Istat, hanno rispettivamente una popolazione di 67.168 e 60351 abitanti, tutti gli altri centri contano meno di 20 mila residenti.
A darci una prima impressione è chi questa terra la studia da una vita. Ettore Bove, docente di Economia e Politica agroalimentare all’Università della Basilicata, non nega che quella demografica sia una vera e propria emergenza, ma è convinto che creando una rete turistica adeguata questo problema si possa arginare. “La Basilicata è divisa in due parti: da un lato abbiamo la polpa che corrisponde alle zone più sviluppate, come Matera e le fasce costiere. Dall’altro, invece, c’è l’osso, ovvero le aree depresse. Questa sorta di dualismo è destinato ad assumere proporzioni maggiori, a meno che non si intervenga”. In particolare, come sottolinea, con il turismo. “È il nostro unico mezzo di contrasto all’abbandono dei territori. Non ne abbiamo altri efficaci come questo. Bisogna individuare e valorizzare le risorse locali, così da creare un’offerta turistica indirizzata verso la cultura, l’ecologia, la scienza. La vera sfida è destagionalizzare la presenza turistica”.

Una delle porte di Irsina ©Veronica Di Benedetto Montaccini 
Terra di grano ©Veronica Di Benedetto Montaccini
In 27 dei 131 Comuni della regione gli abitanti sono meno di mille. Alcuni di questi corrono il rischio di rimanere completamente disabitati nel giro di pochi decenni. In altri, invece, residenti e istituzioni hanno reagito all’emorragia demografica proponendo un’offerta turistica e culturale che ne ha garantito la sopravvivenza e, in alcuni casi, uno sviluppo quasi impensabile fino a pochi anni fa.
Un esempio virtuoso è quello di Irsina, il comune delle colline lucane rinato grazie ai residenti stranieri. Ma c’è anche Borgo Taccone, a pochi chilometri da Irsina, dove vive ormai fissa tutto l’anno una sola famiglia, che sogna di far rinascere il cinema del paese. Un altro caso è quello di Guardia Perticara, un villaggio che ha provato a puntare sul petrolio per salvarsi dalla sua stessa scomparsa, ma che ora che le attività del pozzo sono diminuite è costretto a trovare un altro tipo di oro, magari non nero, per continuare a sopravvivere. Nel frattempo Craco, il borgo evacuato negli anni ’60 per una frana, è diventato set di numerosi film, proprio per la sua peculiarità di non avere più nessun abitante. Mentre a San Paolo Albanese la lingua e i colorati vestiti tradizionali dell’Albania attirano curiosi e storici.
Irsina, un’isola per cittadini del mondo
Arriviamo ad Irsina l’ultimo giorno della festa dedicata a Sant’Eufemia. Una ricorrenza che non è solo un omaggio alla patrona della città, ma un’istituzione per tutta la comunità. In quattro giorni, dedicati alla santa che i leoni si rifiutarono di sbranare, o almeno così racconta la leggenda, Irsina raddoppia e triplica i suoi abitanti, ma finita la festa tutto torna alla normalità.
Oggi i residenti non superano i 5000 abitanti: sono circa 4900 e ogni anno diminuiscono. “Le prime emigrazioni sono iniziate negli anni ’60” racconta Nicola Morea (classe 1978), sindaco di Irsina dal 2015, tornato nella terra natia dopo dieci anni a Milano, dove si è formato come avvocato. “La riforma agraria non stava dando i risultati sperati, sette ettari a testa non erano sufficienti per coltivare il grano, così le famiglie hanno cominciato ad andarsene al Nord, in particolare a Sassuolo, dove stava nascendo il distretto industriale della ceramica, uno dei più importanti nel mondo”.

Irsina ©Veronica Di Benedetto Montaccini 
©Veronica Di Benedetto Montaccini 
Italia dei santi e degli eroi ©Veronica Di Benedetto Montaccini 
Irsina’s landscape ©Veronica Di Benedetto Montaccini
Dalla Basilicata all’Emilia Romagna. Ed è proprio nella campagna modenese che oggi ci si può imbattere in una sorta di filiale di Irsina, anche se a guardare i numeri è qui che c’è la sua sede principale. Sono circa 8 mila le persone che provengono da questo piccolo paese lucano e che attualmente risiedono a Sassuolo, che conta 40 mila abitanti. Un quinto di loro sono irsinesi, e costituiscono di fatto una delle più grandi comunità italiane emigrate dal proprio luogo d’origine. Anche qui, visto che ormai ci sono più abitanti al Nord che nel paese d’origine, si festeggia Sant’Eufemia.
Dagli anni ’80 Sassuolo e Irsina sono gemellati, i sindaci sono amici e stanno lavorando insieme su un progetto per raccontare l’impatto dell’emigrazione lucana sulla città emiliana. Nicola Morea, come altri, è tornato ad Irsina perché ne sentiva forte il richiamo. “Prima o poi le origini, le senti e ti chiamano” racconta mentre ci offre l’ennesimo caffè e ci passa davanti il piccolo mondo di uno dei più antichi paesi della Basilicata. Essere sindaco per lui non è un mestiere, ma una passione a tempo pieno, che non significa solo consigli comunali, decisioni da prendere e carte da firmare. Il suo telefono squilla continuamente, non può fare un passo e qualcuno lo ha già fermato per strada. Sorride, ci lascia un secondo, e poi riprende il filo sulla sua “Irsina bella”. Si ferma un’altra volta, annuisce a chi vuole semplicemente fargli sapere come sta andando il figlio a scuola, e a tratti sparisce perché qualcuno ha bisogno di lui.
Se la guardi dal basso, è tutta arroccata su di una collina a circa 550 metri d’altezza, e da qui Irsina scruta le valli del Bradano e del Basentello, anche se le sue origini risalgono all’Homo Erectus. Nel tempo il suo centro storico ha vissuto un progressivo spopolamento, ma da una decina di anni si è verificata una strana inversione di tendenza, dovuta al grande numero di stranieri che decidono di stabilirsi qui.
“Prima o poi le origini, le senti e ti chiamano”
Irsina oggi cerca infatti di resistere al deserto demografico aprendo le sue porte. A venire qui sono in gran parte pensionati, di classe medio-alta, provenienti da tutto il mondo. Grazie ai prezzi accessibili e alla vicinanza con l’aeroporto di Bari (distante poco più di un’ora) sono molti gli stranieri che decidono di trasferirsi qui alla ricerca della serenità che solo un piccolo borgo può dare. A convincerli a mollare tutto, però, è quasi sempre la vista e il paesaggio che possono osservare dalle loro finestre appena svegli. “Grazie a loro – racconta il sindaco – il nostro centro storico sta vivendo una nuova vita. Ristrutturano e rispettano i materiali, e così molti dei loro investimenti, che hanno superato i sei zeri, stanno trasformando Irsina in un piccolo gioiello del Sud”.
Basta fare un giro nella parte vecchia della città per accorgersi che sui campanelli campeggiano cognomi d’oltreoceano. Negli ultimi anni, a partire dal 2006, sono arrivati Sandy e Ketih, la prima coppia a decidere di comprare casa ad Irsina per trascorrere gli anni della pensione. Da Londra alla Basilicata, per la tranquillità, ma soprattutto per le colline e l’atmosfera. Dopo di loro sono arrivati Ann e Ian, ex giornalista lei e programmatore lui, che sulla loro terrazza nel cuore di Irsina ci offrono vino e specialità locali, in pieno stile italiano. Basta guardargli negli occhi, mentre osservano e si stringono sopra ai tetti di Irsina per accorgersi che, esattamente qui, dopo aver girato mezzo mondo per lavoro, hanno trovato la loro dimensione. Un posto da chiamare “casa”. “Con internet e i social network sei talmente connesso che non serve più abitare a Londra per lavorare!” spiega la giornalista irlandese.

Una famiglia: dalla Nuova Zelanda a Irsina ©Veronica Di Benedetto Montaccini 
Yann e Ann ©Veronica Di Benedetto Montaccini 
La più giovane cittadini straniera del paese ©Veronica Di Benedetto Montaccini
E se c’è chi le abita le case in pietra bianche, c’è anche chi le arreda e le costruisce. Con un gusto locale. Si chiama Rocchina Natale, l’architetta di Irsina adorata dagli stranieri. “Mi lasciano tutto, chiavi, carte di credito, quando tornano nei loro Paesi. Si fidano immensamente, io controllo che tutto vada bene. Tutti mi dicono di aver trovato la pace proprio qui, ad Irsina”. E se fino a dieci anni fa era molto difficile per Rocchina avere un lavoro stabile, adesso c’è la fila per le sue consulenze. I nuovi abitanti, investendo qui, hanno ridato vitalità al paese e indirettamente anche una speranza più concreta ai più giovani, che si sono reinventati.
È mattina presto, e tra la nebbia che si sta aprendo sull’altipiano, scorrazzano degli strani maialini. Basta un fischio e corrono per la quotidiana razione di cibo. A richiamarli è Giuseppe Signoriello, 33 anni. Aveva iniziato gli studi di zootecnia e agraria, ma poi il canto delle sirene delle campagne irsinesi è stato più forte di quello dei libri. Pur di rimanere nella sua città di origine, insieme a due amici ha pensato di recuperare una razza ormai quasi estinta: il suino nero lucano. “Siamo ambiziosi, vogliamo preservare la razza e curare personalmente l’intera filiera: dall’allevamento al ristorante, tutto in casa” spiega Giuseppe. La braceria, nel centro del paese, si chiama Fuoco Divino. Qui i camerieri e i cuochi, che servono portate a base del maialino dal pelo nero, sono tutti ragazzi e ragazze.

Non solo suini neri ©Veronica Di Benedetto Montaccini 
Giuseppe ©Veronica Di Benedetto Montaccini
I giovani ad Irsina non si concentrano solo sulla campagna, dove oltre ai suini neri si stanno sperimentando coltivazioni di canapa e di semi antichi. Angela Pisani, 36 anni, ci aspetta nel suo Irislab, un laboratorio di ceramica che una mattina di giugno di 16 anni fa ha deciso di aprire qui, dove una tradizione ceramica non c’è davvero mai stata.
A parlare per lei vorrebbero che fossero i suoi lavori, le storie che racconta su piatti e tazzine da caffè, usando poesie, aforismi e parole delicate . Da piccola era una bimba timida e introversa, ma si è avvicinata presto alla pittura quando ha scoperto che ci si poteva esprimere anche con piccole pennellate di colore, senza dover dire niente. “Di pane ed arte non si vive” le dicevano i suoi nonni, ma poco importa. Frequenta il liceo artistico, si innamora, diventa mamma, ma non sceglie di andarsene come tutti i suoi coetanei, al contrario rimane. Andarsene sarebbe stato troppo facile, per lei. “La mia – racconta – è stata una scelta: così come il partire anche il restare richiede coraggio, soprattutto quando si va contro corrente”.
“Un giorno ho acquistato il mio forno ceramico, volevo provare l’emozione di bere un caffè, un rito così semplice ma fondamentale, con la mia tazzina, ed è iniziato tutto”, spiega Angela mentre si sistema un ciuffo biondo dietro l’orecchio e decora un piatto nel centro di una piccola viuzza del paese che dà sull’infinito.

Angela Pisani ©Veronica Di Benedetto Montaccini 
Angela e il suo atelier Irisilab ©Veronica Di Benedetto Montaccini
“Ovunque ti affacci da Irsina vedi l’infinito. Qui passeggio molto, raccolgo gli odori e le storie della mia terra e cerco di tradurli in arte. Questo è l’unico posto – racconta mentre con gli occhi cerchiamo l’orizzonte da uno dei tanti punti più panoramici di Irsina – , dove trovo quel silenzio che lascia spazio a me stessa. Lo stesso silenzio che a volte però può diventare assordante. Perché è vero, qui, a volte ci sentiamo soli, ma se apro la cartina mi accorgo che noi (lei, suo marito e i suoi due figli) ci siamo. Siamo esattamente qui”.
Qui Angela riesce a vivere del suo lavoro, con tutte le difficoltà legate all’aver aperto un’attività in un paese. “Devi inventarti ogni giorno qualcosa, serve tanta passione, ma non bisogna arrendersi mai, così come abbiamo insegnato io e mio marito ai nostri figli. Bisogna saper credere in ciò che si fa, altrimenti si finisce per rinnegare un po’ se stessi. Qua mi sento libera, la città non mi è mai mancata, mi organizzo e scelgo il tempo. Serve coraggio, certo, ma voglio dire ai miei coetanei che non serve a nulla vivere in una gran bella città, con certi ritmi e certi orari, se non si riesce a godere delle piccole cose. Qua ci sono tante possibilità, forse siamo noi a non volerle vedere, al di là dei problemi della nostra terra”. Angela sorride, ma ha gli occhi lucidi, soprattutto quando ci parla di amore, la sua forza. La stessa che ha trasmesso ai suoi figli. Uno di loro, quello più grande, sta già seguendo le orme della mamma, sperimenta e tiene gli occhi bene aperti in un orizzonte come quello irsinese che sa anche aprirsi e lasciare andare.
Borgo Taccone, i lotti fantasma
Un’atmosfera surreale, quasi cinematografica. Quando si mette piede a Borgo Taccone, ad interrompere il vuoto e il silenzio sono solo i latrati di un branco di cani randagi. L’asfalto ormai consumato è stato spazzato via da terra e fango, mentre le case crollano, i balconi cadono e i tetti si sfondano sotto il peso dell’incuria.
Taccone, fa parte dei borghi rurali costruiti negli anni ‘50, un agglomerato di lotti pensato per accogliere i lavoratori delle terre circostanti. “I miei nonni si sono spostati qui, c’erano degli incentivi nel periodo della riforma fondiaria. A volte qualche lacrima scappa, ma non possiamo andarcene dalla nostra terra. Altre volte, invece, è proprio la magia di questo posto a regalarci grandi bellezze” a raccontare la vita del borgo è Milena, agronoma, che insieme a suo padre e alla sorella Maria Luigia, sono l’unica famiglia ad essere residente tutto l’anno nel paesino. Gli altri cinque-sei nuclei famigliari che hanno ancora casa a Borgo Taccone si spostano a seconda delle stagioni.

Casa pericolante ©Veronica Di Benedetto Montaccini 
Ricordi ©Veronica Di Benedetto Montaccini 
Borgo Taccone ©Veronica Di Benedetto Montaccini
“Qui c’era un po’ di tutto fino agli anni ‘80 – continua Milena -. Mancava solo la scuola, ma c’era l’alimentari, la chiesa. Ci sono progetti di rilancio nel cassetto, ma per ora non è partito niente. Si spera nell’acquisizione da parte del comune del vecchio cinema, dove i contadini andavano a passare del tempo”. Per trovare l’entrata, bisogna farsi largo tra l’erba molto alta e le spine, una volta spinta una porta rossa che scricchiola, lo sguardo si allarga su una sala spoglia, piena di escrementi di piccione, dove il susseguirsi delle pellicole si può solo immaginare. Un piccolo Nuovo Cinema Paradiso, tutto da rifare.
“Mio padre Antonio lavora in campagna, chi non vive qui non riesce a capire la nostra scelta. Ma alla fine abbiamo tutti i servizi, l’acqua, la corrente, la nettezza urbana. Siamo a stretto contatto con la natura. Mio padre morirebbe lontano dai campi, e io mi sposto per la provincia per fare le mie consulenze da agronoma”. Passeggiando, si arriva alla vecchia ferrovia. All’orizzonte colline dal verde acceso e grano che germoglia. L’oro di Antonio che, prima di ripartire, ci mette da parte in un piccolo sacchetto, un amuleto da portare con noi. E mentre Cristo si è fermato a Eboli, nella stazione di Borgo Taccone non si ferma neanche più il treno.
Giuseppe Las Casas, docente di tecnica e pianificazione urbanistica all’Università della Basilicata, ha dedicato una buona parte dei suoi studi ai centri con pochi abitanti e sembra avere le idee molto chiare. “Se estendiamo il concetto di disastro alla componente sociale, allora possiamo dire che l’abbandono dei territori è un vero e proprio disastro. L’unico metodo per arginare lo spopolamento dei comuni lucani è ripensare il modo in cui si erogano i servizi agli abitanti attraverso una gestione condivisa e, quindi, unitaria, dei servizi. È un’idea di cui si parla ma che non trova applicazioni concrete. Un tema importante, a questo proposito, è quello dell’isolamento. In molti pensano di risolverlo facendo le strade. Ma le vie, poi, devono essere percorse. Se io faccio strade che collegano posti in cui l’età media degli abitanti è molto alta, come potranno usufruirne se non garantisco loro anche il trasporto pubblico?”.
Milena e la sua famiglia di quello che dice il professore Las Casa ne sanno qualcosa: “Paghiamo le tasse esattamente come gli altri cittadini italiani senza ricevere lo stesso trattamento”. I trasporti e le infrastrutture hanno certamente affossato i piccoli paesi della Basilicata. “Ma non per questo ci arrenderemo, con le nostre competenze in agricoltura e in tecnica ambientale ci piacerebbe far diventare questa area un punto di riferimento per le tradizioni biologiche e di permacultura lucane. Per esempio se non la preserveremo, la varietà di grano Capello, usata per le paste migliori, qui andrà persa”.
Nonostante le crepe nella chiesa impolverata ormai chiusa al pubblico, nonostante le buche nelle strade, nonostante i cancelli sbarrati delle villette che una volta erano le case dei contadini, Milena non ha un’aria nostalgica. Con un sorriso impreziosito dal rossetto amaranto, non si abbandona alla cupezza come il suo borgo fantasma. Anzi, parla solo bene del luogo e delle sue radici che sente qui più che altrove: “Cosa mi tiene qua? La bellezza del cielo quando non ci sono le nuvole di notte, qui si ammira un panorama cosmico incredibile. Quando è completamente buio, guardo le stelle e mi dico: ma chi altro ha una porzione di cielo così?”.

Il vecchio cinema ©Veronica Di Benedetto Montaccini 
Tonino e la stazione fantasma ©Veronica Di Benedetto Montaccini
Guardia Perticara, cultura e petrolio
Lo chiamano “Il paese delle case di pietra” per il materiale con cui sono stati costruiti gli edifici del suo centro storico. Negli anni scorsi la maggior parte delle case di Guardia Perticara, comune della Val d’Agri, che fa parte del circuito dei borghi più belli d’Italia, erano vuote.
A risollevare le sorti demografiche del Comune, che fino al 31 agosto 2017 contava 542 residenti, è arrivato il petrolio da qualche anno. L’incremento dell’attività estrattiva nella zona, con tutte le polemiche e le contraddizioni che ha portato con sé, per gli abitanti di Guardia Perticara è stato un vantaggio, almeno in termini economici. I lavori di costruzione del nuovo Centro Oli della Total hanno portato nell’area centinaia di maestranze. I lavoratori risiederanno nella zona fino a quando l’impianto non sarà attivo. “Da qualche anno a questa parte sul nostro comune gravitano molte più persone di prima – racconta il sindaco, Angelo Mastronardi –, la popolazione effettiva è quasi raddoppiata e la maggior parte delle case, prima disabitate, sono affittate”. Una ricaduta positiva, secondo il primo cittadino, anche da un punto di vista lavorativo.
Giacomo, Enzo e Luigi sono tre lavoratori del petrolio sulla quarantina che incontriamo nella piazza principale del paesino. L’ora è perfetta: sono le 18 e un esercito di tute arancioni fa ritorno in città dallo stabilimento della Total. Le mani sporche di grasso dell’olio, le fronti abbronzate. “Vengo dalla Calabria – spiega Giacomo – mi trovo bene qui. Ci hanno dato delle casette a prezzi scontati e la sera ci ritroviamo con gli altri operai, si è creata una comunità”.

Working class hero ©Veronica Di Benedetto Montaccini 
Generazioni a confronto ©Veronica Di Benedetto Montaccini
Questa specie di boom economico che vede protagonista il centro della Val d’Agri non è, però, destinato a durare in eterno: “Non si può negare che in questo momento nella filiera del petrolio il lavoro per i giovani ci sia, quello che si sottovaluta è che questa occupazione è legata al presente. Quando la costruzione del centro sarà ultimata e l’impianto funzionerà ci sarà bisogno di un numero inferiore di lavoratori” afferma il sindaco. A quel punto, la disoccupazione potrebbe tornare ad essere un problema. E già sta succedendo, da dicembre gli operai assunti dalla Total per questo giacimento sono stati dimezzati. “Per chi è interessato a lavorare nella filiera del petrolio, al momento, ci sono molte possibilità – dice Lucia, una ragazza di Guardia Perticara che frequenta l’Istituto alberghiero a Potenza e d’estate lavora nell’unico bar della piazzetta del paese. “Chi vuole fare altro però non ha molta scelta. Alle persone che vengono da fuori, Guardia piace perché ne apprezzano la tranquillità. Ma per chi vive qui è diverso: c’è un solo negozio di alimentari e non c’è modo di comprare vestiti”. Sulla possibilità di costruirsi un futuro nel suo paese dice: “Ancora non ho deciso cosa farò nella vita, ma non escludo che me ne andrò presto da qui”.
Ad andarsene Da Guardia Perticara, negli corso del tempo, sono stati in tanti, al punto che da due anni è stata chiusa la scuola secondaria di primo grado, perché gli alunni iscritti non bastavano a tenerla in piedi. “I ragazzi frequentano le scuole medie ad Armento o a Corleto Perticara, i paesi più vicini”, spiega il primo cittadino.
Da Guardia ci si deve spostare non solo per studio, ma anche per svago. Il cinema più vicino, ad esempio, è a Potenza: per vedere un film sul grande schermo bisogna percorrere 60 chilometri di curve, su una strada che d’inverno non è delle più agevoli. Per sopperire a questa mancanza, il sindaco ha pensato di mettere a disposizione un pulmino che porti gli abitanti fino al cinema potentino, ma l’idea non è stata particolarmente apprezzata dalla cittadinanza: “Siamo riusciti ad organizzarci solo per andare a vedere la proiezione di un film di Natale”, dice con rammarico il primo cittadino.
“Per chi è interessato al petrolio, il lavoro non manca. Il problema è per gli altri”
Nonostante la scarsità di strutture, il Comune da anni si impegna per assicurare un’offerta culturale agli abitanti e ai turisti che arrivano a Guardia. In cantiere ci sono quattro esposizioni permanenti, che saranno realizzate in un palazzo storico del paese. In passato, invece, è stata garantita l’apertura della biblioteca comunale: “Poiché in paese non arrivano i giornali – racconta il sindaco – l’amministrazione precedente aveva pensato di tenere aperta la biblioteca del municipio e di fare arrivare lì giornali e riviste. La struttura era gestita dai giovani del paese, che si alternavano ogni due mesi”. Poi la graduatoria si è esaurita e, per il momento, la struttura è chiusa.
La biblioteca, però, non ha perso la sua importanza e ha ricevuto da poco un’importante donazione da parte di una persona molto legata al paese, come ci raccontano: “Mio padre era un uomo molto colto. Aveva una biblioteca di circa 2000 volumi che, dopo la sua morte, non avrei potuto conservare in casa. Ho deciso così di donarla a Guardia, il paese dove era nato e al quale era legatissimo, come invito alla lettura e alla riscoperta della cultura”. A raccontare com’è nata l’idea di donare i libri del padre alla biblioteca guardiese è Rosi Massari, avvocata milanese e figlia di Franco, medico e docente universitario originario del paese della Val d’Agri. “Mio padre aveva un grande amore per il suo paese natale – continua – e l’ha trasmesso anche a me. Nonostante sia nata e cresciuta a Milano, considero questo Guardia come uno scrigno di valori autentici, quasi un’isola felice. Per questa ragione, non vorrei vederla morire”.
Rosi torna in paese ogni estate e organizza in paese eventi culturali; l’ultimo, “AvanGuardia”, è un festival dedicato all’arte in tutte le sue forme. “Perché la cultura – conclude – porta ad avere consapevolezza della bellezza che possiede la propria terra e a valorizzarla. È ciò che vorrei accadesse anche a Guardia”.
Craco, un set a cielo aperto
È l’esempio più tangibile di una grande contraddizione: il borgo antico, disabitato da decenni a causa di una frana, è meta di turisti e curiosi. La parte nuova, invece, è un luogo anonimo, triste, popolato da poche persone che devono spostarsi nei centri limitrofi per usufruire dei servizi che nell’agglomerato di case dove si trovano a vivere non sono garantiti.
“Pane e lavoro”. In rosso sbiadito, la rivendicazione, scritta dai contadini prima della riforma agraria, si intravede sulla facciata di palazzo Grossi, dimora dei latifondisti del luogo. Craco, piccolo centro della provincia materana, fino agli anni ‘60, era il paese del grano. Se ne produceva talmente tanto che i 2000 abitanti non bastavano a coltivare le terre delle famiglie benestanti. La manovalanza arrivava anche dal Salento.

©Veronica Di Benedetto Montaccini 
Le case nella roccia ©Veronica Di Benedetto Montaccini 
Craco e il gregge ©Veronica Di Benedetto Montaccini
Quelle terre, redistribuite dopo la riforma, oggi non sono coltivate. L’Unione europea paga i proprietari perché le tengano a riposo. Quel paese, arroccato su un’altura e circondato dai calanchi, già terra di conquiste normanne e bizantine, non esiste più. La sua morte è cominciata nel 1963, quando una frana ha iniziato a mettere in pericolo le case e le persone che ci vivevano. Fu un cedimento lento che poteva essere fermato. A peggiorare la potenza distruttiva è stata anche la cecità dell’uomo. “Un ingegnere americano, nel 1967, quando la frana era profonda 20 metri, aveva suggerito di creare dei terrazzamenti alberati. I tecnici del posto, però, preferirono costruire due grossi muri di contenimento che iniziarono dare i primi segni di cedimento cinque giorni dopo la costruzione. A partire dal 1974 gli abitanti fummo costretti a lasciare il paese”. A raccontare questa storia sono Antonio e Mafalda, una coppia resistente che abita nelle case popolari, completamente vuote, alle pendici di Craco vecchia.
Gli hanno assegnato l’abitazione proprio dopo la frana. “Dovevate venire a vederlo quando era vivo il paese, non ora che è morto”, scherzano marito e moglie, accarezzando la testa di un grande pastore maremmano.Quello rimane oggi è uno scenario di bellezza antica, da decenni scelto per girare film e cortometraggi. In tanti, da Francesco Rosi a Mel Gibson, l’hanno selezionata per realizzare scene dei loro film. Per il Comune, che dal 2009 ha iniziato un’opera di valorizzazione del centro storico, le riprese sono fonte di introito. Per entrare, dichiarando di non fare foto, devi pagare 15 euro. Se vuoi fare riprese 40, ma se vuoi farci un film gli zeri aumentano.

Antonio e Mafalda ©Veronica Di Benedetto Montaccini 
Il cielo sopra Craco ©Veronica Di Benedetto Montaccini
Nonostante il pedaggio all’entrata, come in un parco dei divertenti, sempre più turisti rimangono colpiti dall’affascinante desolazione che si respira tra i vicoli di Craco: “Nel 2010 hanno visitato il sito 1.500 persone. Nel 2016 erano 15.000 – racconta Antonio, offrendoci un crodino -, con questa operazione il luogo è stato salvato dall’azione dei vandali, del tempo e delle capre che, indisturbate si aggiravano tra le stradine del paese”. Dopo anni di oblio, insomma, l’amministrazione, insieme a una cooperativa composta da una quindicina di persone, sta facendo rifiorire questo luogo. Un luogo che, contrariamente a quanto sostenuto da Rocco Papaleo nel suo “Basilicata coast to coast”, non ha “rifiutato la modernità”, ma è stato distrutto in parte dalla natura, in parte dall’incuria.
I vicoli di Craco non potranno essere più popolati da chi tra quelle pietre era nato e cresciuto, né dai suoi figli, ma quelle case restano lì, in bilico e, nonostante le crepe, resistono al tempo, per ricordare quanto male possano fare la superficialità degli esseri umani.
San Paolo Albanese, tradizioni in via d’estinzione
San Paolo Albanese è il paese più piccolo della Basilicata. In 10 anni 100 abitanti in meno: il borgo fondato dagli albanesi che scappavano dai turchi rischia di sparire in pochi anni. Seduta davanti alla porta della suo bar, Paola asciuga i bicchieri. Se le si chiede quanto ci vorrà ancora prima che il lavoro sia finito, risponde che ci vuole tempo e pazienza.
Fatica a parlare l’italiano, un po’ per timidezza, un po’ perché l’italiano non è la sua lingua natia. Paola, 26 anni è una delle poche giovani tra le 263 persone che abitano a San Paolo Albanese, uno dei cinque paesi lucani di origini arbëreshë. Fu fondato nel XVI secolo da una comunità di profughi albanesi che scappavano dall’invasione dei turchi ottomani.
“Nell’ultimo decennio abbiamo perso 100 abitanti. E la cultura
arbëreshë rischia di morire peer sempre”
Delle loro origini, gli abitanti di San Paolo albanese – la maggior parte anziani, basti pensare che l’età media del paese è 54,2 anni, contro i 45,7 della regione – conservano la lingua e le tradizioni religiose. Se li si incontra tra le strade semideserte del paesino, è facile sentirli parlare tra di loro in albanese antico, una lingua che custodiscono gelosamente, anche se a conoscerla bene sono sempre di meno. “Il nostro paese ha subito un forte spopolamento. Nell’ultimo decennio abbiamo perso 100 abitanti. Una media di 10 persone in meno all’anno”, spiega Maria, guida turistica del paese . “San Paolo è un paese molto bello, ma la vita quotidiana qui è difficile” racconta. Maria è anche responsabile di uno scrigno che conserva gli usi e i costumi di San Paolo: si tratta del Museo della cultura arbëreshë, dove in poche stanze si può ripercorrere la filiera della lavorazione della ginestra, dalla quale si ricavava il filo per i tessuti, ed osservare gli abiti tradizionali del paese.
Se si vive in un posto così piccolo è necessario spostarsi per qualsiasi tipo di esigenza. A volte, anche per comprare il pane. Ad eccezione di un emporio che vende un po’ di tutto, infatti, in paese non c’è altro. Non una macelleria, non un negozio di abbigliamento, non un ufficio postale. Il medico di guardia di notte è non è presente e dal 2011 è stata chiusa anche la scuola primaria. L’assenza di scuole in paese comporta il rischio che i bambini che non parlano l’arbëreshë in famiglia non abbiano modo di imparare la lingua della loro comunità.
C’è un modo, però, per toccare con mano la tradizione, ed è a pochi passi dal museo, nella chiesa del paese. Lì viene celebrata la messa con il rito greco bizantino, tipico delle popolazioni arbereshe. Ogni domenica le campane suonano e, uno dopo l’altro, senza particolare attenzione all’orario prestabilito, i fedeli arrivano. Quando la chiesa è piena, il parroco inizia la celebrazione.
Tra quelle panche, piene di persone con i capelli bianchi che cantano inni in arbëreshë, il paese che sta morendo sembra vivo e lo spopolamento uno sparuto miraggio, un’invenzione di sociologi venuti da lontano.

Paola ©Veronica Di Benedetto Montaccini 
Una nonna arbëreshë ©Veronica Di Benedetto Montaccini 
Luigina, la cuoca ufficiale di San Paolo Albanese ©Veronica Di Benedetto Montaccini
“Nelle aree interne, nei paesi, dove qualcuno vede solo il passato, io vedo il presente, ma soprattutto il nostro futuro”. Lo scrive, lo ripete da anni ormai, Franco Arminio. Il poeta lucano dei nostri tempi più famoso. Vive in un piccolo borgo, a Bisaccia, e con i suoi versi ha conquistato un vasto pubblico di lettori, raccontando la bellezza delle piccole cose soprattutto attraverso i suoi post su Facebook. Di professione si definisce un paesologo, un narratore del piccolo e non del grande. Per lui ogni luogo è ricerca del dell’uomo, è resistenza al tempo. Quando aveva nove anni era un tipo strano, e non ha pensato neppure per un attimo di andare via dal suo paese. Suo nonno era un comunista ed emigrò in America quando era già vecchio, suo padre era un oste e mia madre un pugno di grano.
“Sono nato nel 1960. Quando ero piccolo in casa non c’erano giochi – racconta il poeta -, il mondo dei bambini era il fuori, il paesaggio. Fare il paesologo significa proprio questo: avere un legame con il paese che si tramuta nell’avere una forma di attenzione a luoghi che spesso non ricevono attenzioni. Spesso i paesi si svuotano, quello che cerco di perseguire io, è una sorta di via di mezzo fra l’etnologia e la poesia: l’esterno e l’interno si incontrano e si completano. La poesia per me è soprattutto impegno civile, assumere uno sguardo combattivo”.
Tra i suoi libri più famosi c’è “Cedi la strada agli alberi” (Chiarelettere, 2017), dove scrive:
“Non toccate la Lucania, e non toccate i contadini, quelli di adesso e quelli che furono macellati a Caporetto, non toccate quelli che presero le navi per andare in America, non toccate chi ha lavorato in Svizzera e chi è rimasto innocente in questi paesi in cui ogni disperazione è sola nel suo fosso, ditelo a chi è rimasto che bisogna salutarsi con gioia, che bisogna pulire fuori dalla nostra casa prima che dentro, ditelo che non bisogna chiedere favori, ditelo che non siamo in vendita e chi ci ha rubato le braccia ora ci ruba il vento e l’acqua e il petrolio. Chi non sa nulla del Sud stia zitto, parli chi ha il coraggio di starci dentro di attraversarlo lentamente. Stia zitto chi fa il giornalista nei salotti. Non servono i mestieranti dello sdegno, i mercanti del frastuono, per raccontare certi luoghi ci vuole la poesia, il teatro, il canto”.
“E allora corri, corri! Corri verso la tua terra che ti sta aspettando. Questa terra grano e sole. Questa terra che è solo allegria”, risuona ancora dalla nostra auto la canzone in dialetto del cantautore Pietro Cirillo che ci ha accompagnato in questo lungo viaggio.
Con i dati alla mano, la Basilicata sembrerebbe essere sul punto di morire , e il rischio ogni giorno che passa diventa sempre più concreto. Mentre lasciamo la Lucania, ci voltiamo. All’orizzonte ci piace immaginare lo sguardo, fermo e orgoglioso, dei tanti giovani che abbiamo incontrato e che hanno scelto di darsi una possibilità, qui e ora nella loro terra. “Perché le radici, ad un certo punto, le senti”. E chiamano.